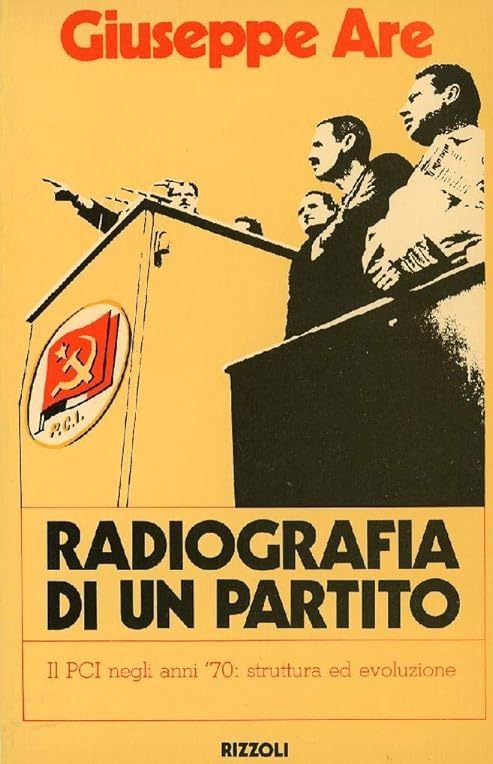All’interno di un clima sociale segnato da una marcata rottura, quello dell’insediamento delle giunte rosse è un processo che si dispiega in un arco temporale compreso fra due tornate di voto, dal 15 giugno 1975 al 20 giugno 1976. Il biennio 1975-76 rappresenta il «punto apicale di una parabola politica» <50 e sembra l’esito naturale dell’onda lunga del ’68 e dei suoi impulsi di rinnovamento <51. Sono i riflessi sociali e culturali delle energie sprigionate dalla contestazione sessantottesca a ridisegnare le coordinate generali della società italiana e condurre all’«episodio più rilevante delle consultazioni substatali della Prima Repubblica» <52. «L’Italia volta pagina?» <53 si chiede «L’Espresso» alla vigilia del voto, cogliendo aspettative e tensioni attorno ad una tornata elettorale rappresentata come una possibile cesura <54. Nelle consultazioni del 15 giungo per il rinnovo degli organi di governo negli enti locali i comunisti si attestano al 33.4% dei voti (con un incremento del 6.2% rispetto alle politiche del 1972), proiettandosi al governo di sette regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria) e di molte fra le principali città italiane (Firenze, Milano, Napoli, Torino, Venezia) <55. L’ampliamento del tradizionale perimetro di agibilità politica del Pci proietta la questione comunista come questione nazionale e obbliga l’opinione pubblica al riconoscimento della centralità delle forze sociali che lo favoriscono.
Il voto del 15 giugno esprime un insieme di protesta e proposta, attraverso uno sviluppo «quantitativo e qualitativo» <56 della partecipazione democratica, testimoniato da un’affluenza alle urne senza precedenti. Il radicamento sociale del Pci evidenzia la correlazione tra «consenso elettorale e organizzativo» <57 come motore del lento ma costante processo di crescita. Il partito guidato dal segretario Enrico Berlinguer contribuisce attivamente alla propria fortuna elettorale attraverso la proiezione di un’efficace auto-rappresentazione di rigore ed efficienza. La sua «nuova immagine» <58 concorre ad affermarne il progetto all’interno dei grandi centri urbani dove le parole d’ordine dei comunisti e la narrazione del buon governo favoriscono un dialogo con i soggetti sociali più diversi. «Compostezza» <59 e capacità organizzative, insieme alla percezione di una sostanziale estraneità alle pratiche predatorie della «democrazia dei partiti», emergono come tòpoi narrativi ricorrenti nelle inchieste di matrice sociologica e politologica che numerose affollano la letteratura scientifica nel periodo <60. Si ritiene l’allargamento al Pci delle responsabilità del governo nazionale auspicabile per superare lo stallo, morale ed istituzionale, che appanna la politica italiana. In altre parole, il Pci si trova «nella situazione migliore per perfezionare e stabilizzare i contatti occasionali di ogni genere che le mobilitazioni precedenti e quelle in corso le avevano permesso di avere con gruppi e classi sociali prima assai difficilmente o solo sporadicamente raggiungibili» <61.
I problemi posti dalla gestione dell’«elettorato più ampio e diversificato che si fosse riversato su un partito comunista in elezioni libere» <62 stimolano un inevitabile ripensamento identitario. Impulsi, sollecitazioni e istanze di cambiamento di larga parte della cittadinanza intercettano infatti la vitalità di un ceto amministrativo portatore di nuovi linguaggi e metodi, saldandosi ad un clima sociale e culturale desideroso di novità. In questi due anni si evidenziano inoltre i profondi mutamenti che attraversano la società italiana e che definiscono importanti riassetti nelle culture politiche, nella sfera dei consumi e nella gestione ed interpretazione degli spazi urbani. Al centro del dibattito si pone quindi la scoperta di «un paese diverso»: “Non è la prima volta che un partito raccoglie, a un tratto, un consenso vasto nel Paese. Ma non è un 18 aprile alla rovescia. Allora, spinte eterogenee si coagularono momentaneamente, nella paura, per la difesa da una minaccia; oggi emerge una tendenza di fondo che raccoglie certo proteste e spinte diverse, ma che ha radici lontane: i sorprendenti progressi comunisti sono il risultato di un’accelerazione inevitabile via via che la crisi dello Stato, il disordine politico e l’incertezza economica si fanno più gravi. Non c’è un elettorato stretto in difesa per paura di qualcosa, ma un elettorato di diverse provenienze, che chiede d’essere organizzato per ottenere qualcosa, e che non ha paura” <63.
Alle paure che il risultato suscita in ambienti internazionali agitati dall’avanzata rossa corrisponde, in Italia, il riconoscimento delle incognite aperte dal voto <64: l’«esaltante avanzata» <65 dà corpo alla questione comunista arando il terreno sul quale si sarebbe costruisce l’impasse del partito nella seconda metà degli anni settanta.
A favorire un massiccio spostamento a sinistra contribuiscono dei mutamenti intercorsi nella sfera sociale del paese. Gli assetti sociali integrano quelli demografici attraverso l’ingresso di nuove classi d’età nell’arena politica e sulla scena pubblica. L’abbassamento della soglia di voto da 21 a 18 anni obbliga adesso i partiti ad un confronto, non sempre facile, con una nuova coorte generazionale di elettori ed eletti <66. L’allargamento del suffragio ai diciottenni scompagina gli equilibri preesistenti e risulta decisivo nell’assegnare due terzi dei nuovi voti al Pci, segnalando quel «desiderio di novità» <67 che alcuni osservatori del tempo giudicano complementare al voto referendario. Il “no” all’abrogazione della legge sul divorzio del 1974 aveva attestato l’impossibilità di arginare le spinte secolarizzatrici della società italiana che, trasversali a ideologie e scelte partitiche, provocano una più «vasta destrutturazione del rapporto tra autorità e libertà» <68. I fermenti dell’universo giovanile si accompagnano all’emergere della questione femminile. Il consenso delle donne al Pci è favorito dalle mobilitazioni nelle lotte per la scuola, per l’asilo nido e per l’ottenimento del diritto di famiglia <69, nonostante una notevole «inadeguatezza culturale» del partito comunista rispetto alle teorizzazioni del rapporto fra pubblico e privato avanzate dai collettivi femministi <70. Lo sforzo ostinato di un avvicinamento alla Dc e l’incertezza nell’affrontare il processo di modernizzazione impediscono ad un’elaborazione critica, strutturata attorno al genere e alla sua dimensione politica, di trovare ancora in questa fase un’adeguata collocazione nella cultura politica comunista.
Sul versante parlamentare, una direzione clientelare del potere rinnova ad oltranza la conventio ad excludendum nei confronti del partito comunista. L’immagine della Democrazia cristiana e degli altri partiti al governo è compromessa dagli scandali, in una prassi collaudata che si sottrae alle regole della grammatica democratica. Tale «cadaverica governabilità»71 diffonde nel Paese la percezione della precarietà delle basi sociali dei governi a guida Dc e l’eco dell’«ingloriosa fine» <72 di una egemonia trentennale contribuisce a decifrare l’apertura che ampi strati dell’opinione pubblica e del variegato panorama intellettuale accordano al Pci, in un processo di avvicinamento non scevro da polemiche e accuse di trasformismo. Gli «intellettuali usati come fiore all’occhiello» <73, come li definisce Giorgio Bocca, sono in realtà lo specchio di un più profondo trend di mobilità elettorale destinato a durare nel lungo periodo <74.
Alla luce di queste considerazioni appare chiaro come il balzo in avanti del Pci finisca per generare grandi aspettative ma anche vistose preoccupazioni in vista delle successive elezioni politiche del giugno 1976 <75. Queste ultime sembrano poter marcare quella forte discontinuità il cui bisogno è avvertito con crescente intensità in ampi settori della cittadinanza e del mondo del lavoro. Il paventato «sorpasso a sinistra» <76, preconizzato da Scalfari sul neonato quotidiano «la Repubblica», tuttavia non si realizza, poiché il recupero della Dc infrange le aspettative di un cambio di passo in Parlamento, rinviando il tanto atteso scardinamento del blocco del sistema politico <77.
[NOTE]
50 P. Capuzzo, Prefazione, in Id., (a cura di), Il Pci davanti alla sua storia: dal massimo consenso all’inizio del declino, Roma, Viella, 2019, p. 8.
51 All’interno dell’ampia letteratura sul sessantotto ci si limita a rinviare a P. Ortoleva, Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e in America, Roma, Editori Riuniti, 1988; L. Passerini, Autoritratto di un gruppo, Firenze, Giunti, 1988; A. Agosti, L. Passerini, N. Tranfaglia, La cultura e i luoghi del ’68, Roma, Franco Angeli, 1991; M. Flores, A. De Bernardi, Il Sessantotto, Bologna, il Mulino, 1998; D. Giachetti, Un Sessantotto e tre conflitti: generazione, classe, genere, Pisa, Bis edizioni, 2008; Sulle pratiche discorsive di quella stagione: A. Martellini, All’ombra delle altrui rivoluzioni. Parole e icone del Sessantotto, Milano, Mondadori, 2012.
52 F. Malgeri, L. Paggi (a cura di), Partiti e organizzazioni di massa, cit., p. 152.
53 15 giugno. L’Italia volta pagina?, in «L’Espresso», 15 giugno 1975.
54 Per un’accurata analisi sul voto si legga C. Ghini, Il terremoto del 15 giugno, Milano, Feltrinelli, 1976. Sul significato storico-politico delle consultazioni del 15 giugno è invece S. Colarizi, Storia dei partiti nell’Italia repubblicana, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 288-291.
55 Risultati delle comunali in 52 capoluoghi, in «Corriere della sera», 18 giugno 1975.
56 A. Agosti, Storia del Partito comunista italiano, cit., p. 106.
57 R. Mannheimer, Vecchi e nuovi caratteri del voto comunista, in M. Caciagli, A. Spreafico (a cura di), Vent’anni di elezioni in Italia. 1968-1987, Padova, Liviana Editrice, 1990, p. 44.
58 Cfr. G. Siani, La nuova immagine del Pci e l’elettorato italiano, in D. Blackmer, S. Tarrow, ll comunismo in Italia e Francia, Milano, Etas, 1976, pp. 323-356.
59 Compostezza per il domani, in «Il Sole 24 ORE», 18 giugno 1975.
60 In particolare i risultati di una indagine su un campione di attivisti del Pci e della Dc condotta nell’ambito di un vasto insieme di ricerche su alcuni aspetti della partecipazione politica in Italia che l’Istituto di studi e ricerche “Carlo Cattaneo” ha realizzato fra il 1963 e il 1965. dell’Istituto Cattaneo. La prima, A. Manoukian (a cura di), La presenza sociale del Pci e della Dc, Istituto Carlo Cattaneo, Vol I., Ricerche sulla Partecipazione politica in Italia, Bologna, il Mulino, 1968, esamina la presenza e la capacità di penetrazione del Pci e della Dc prendendo in esame le organizzazioni fiancheggiatrici. La seconda, G. Poggi (a cura di), L’organizzazione del Pci e della Dc, si rivolge alla disamina della evoluzione delle strutture organizzative del Pci e della Dc mentre nella terza, F. Alberoni (a cura di), L’attivista di partito. Un’indagine sui militanti di base nel Pci e nella Dc, si esplorano i circuiti di socializzazione politica dei militanti. Il militante viene definito quale attore «normativamente solido, moralmente fiducioso» che «rimane entro i confini della sua sottocultura politica» e «riafferma continuamente le sue norme speciali». Gli autori distinguono anche tra elettori, simpatizzanti e militanti. Altre due inchieste coeve analizzano le immagini elaborate dai militanti di base dei due grandi partiti di massa: A. Marradi, Immagini di massa della DC e del PCI, in A. Martinelli e G. Pasquino (a cura di), La politica nell’Italia che cambia, Milano, Feltrinelli, 1978, pp. 140-150; S. Belligni (a cura di), La giraffa e il liocorno. Il Pci dagli anni ’70 al nuovo decennio, Milano, Franco Angeli, 1983. L’apporto di conoscenze empiriche sistematiche verte in questo volume su talune aree cruciali nella vita del partito: il personale politico centrale e periferico, la base dei militanti, i sindacalisti, la morfologia organizzativa, le sottoculture territoriali. Viene posto al centro dell’indagine un quesito centrale, se il Pci stia diventando o meno un partito socialdemocratico.
61 G. Are, Radiografia di un partito, cit., p. 18.
62 A. Agosti, Storia del Partito comunista italiano, cit., p. 107.
63 Una vittoria troppo grande, in «Corriere della Sera», 18 giugno 1975.
64 Una svolta a sinistra, in «Il Messaggero», 17 giugno 1975; Il più grosso balzo in avanti dei comunisti in 30 anni, in «The Times», 18 giugno 1975; Una lezione elettorale, in «Daily american», 18 giugno 1975.
65 Esaltante avanzata del partito comunista, in «l’Unità», 17 giugno 1975.
66 D. Calanca, Giovani tra storia e memoria: una rivoluzione silenziosa (1960-1980), in P. Dogliani (a cura di), Giovani e generazioni nel mondo contemporaneo. La ricerca storica in Italia, Bologna, CLUEB, 2009, pp. 23-30.
67 Desiderio di novità, in «Corriere della Sera», 17 giugno 1975.
68 A. Giovagnoli, La repubblica degli italiani. 1946-2016, Roma-Bari, Laterza, 2016, p. 83.
69 Una ricostruzione della presenza delle donne in politica si trova in A. Rossi-Doria, Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne, Roma, Viella, 2007.
70 Il rapporto fra Pci e questioni di genere è affrontato con grande attenzione in A. Tonelli, Gli irregolari, cit.
71 S. Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana, cit., p. 406.
72 G. Crainz, Il Paese mancato, cit., p. 530.
73 L’espressione è usata da Giorgio Bocca durante un’intervista ad Arrigo Benedetti in «L’Espresso», 15 giugno 1975, p. 11.
74 Cfr. M. Caciagli, A. Spreafico, Introduzione, in Id., (a cura di), Vent’anni di elezioni in Italia, cit., pp. VII-XXII.
75 Un’analisi approfondita si trova in A. Parisi, G. Pasquino (a cura di), Continuità e mutamento elettorale in Italia. Le elezioni del 20 giugno 1976 e il sistema politico italiano, Bologna, il Mulino, 1977.
76 Oggi si decide per il sorpasso a sinistra, in «la Repubblica», 20 giugno 1976.
77 A. Parisi, G. Pasquino, Continuità e mutamento elettorale in Italia, cit., pp. 91-96.
Marco Gualtieri, La città immaginata. Le Estati romane e la “stagione dell’effimero” (1976-1985), Tesi di dottorato, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Anno Accademico 2019-2020
 Cenni di Storia della Resistenza nell’Imperiese (I^ Zona Liguria)
Cenni di Storia della Resistenza nell’Imperiese (I^ Zona Liguria)- Un giovane caduto partigiano accomunato nella memoria all'eroico Baletta ed a un patriota di Bordighera
- Portare nottetempo agenti segreti tedeschi
- Era partita una donna con l'incarico di spiare i garibaldini
- Dal fronte a Savona le truppe tedesche ammontano a circa 4000 uomini, tutti appartenenti alla 34^ Divisione
- Il capitano Bentley, appena finita la guerra, raccontava...
- Per tedeschi e fascisti gennaio 1945 avrebbe dovuto segnare la fine dei "banditi" partigiani nel ponente ligure
- Massabò riferisce della situazione delle bande nella provincia di Imperia, bande che sarebbero in gran parte comuniste
- Lo svolgimento del processo non piaceva all'amministratore della Divisione Garibaldi
- La salma di Ivanoe Amoretti è oggi custodita nel sacello 103 del Mausoleo delle Fosse Ardeatine insieme a quelle delle altre vittime dell’eccidio
- La recluta partigiana non conosceva ancora il comandante garibaldino
 Cenni storici sulla Resistenza Intemelia
Cenni storici sulla Resistenza Intemelia- Bombardamenti a Bordighera ad inizio 1945
- Il 30 aprile 1944 Pigna entrò nell'incubo
- Isolabona diede al movimento diciotto partigiani che combatterono incorporati nei vari Distaccamenti della V Brigata
- Patrioti di Ventimiglia, martiri della furia nazifascista e deportati
- Dopo lo sbarco alleato in Provenza erano giunte a Camporosso altre truppe tedesche
- Pajetta indicava ai partigiani imperiesi i collegamenti di frontiera
- La base alleata in Francia era a Saint Jean Cap Ferrat, nella baia di Villafranca, nella villa Le Petit Rocher
- Noi avevamo a che fare con gli americani che comandano questo fronte
- Sono dunque costretti a rinunciare al viaggio in Corsica e a ritornare a nascondersi nella casa di Beppe Porcheddu
- Aiutarli a scappare per raggiungere la zona partigiana
 Adriano Maini
Adriano Maini- Di aerei e di colline nella zona Ventimiglia-Bordighera durante l'ultima guerra
- La donna, residente a Bordighera, venne ritenuta responsabile di collaborazione con i tedeschi
- Aperitivi a Mentone
- La focaccia di Finale
- Quando si passava la sabbia nel fiume
- Rosso, bianco e...
- Partire da Sanremo per degustare a Ventimiglia baguette farcite con acciughe e cipollotti
- Reganta
- Simulare con una mano la presenza di una pistola
- Collasgarba, semplicemente
 Collasgarba
Collasgarba- L’amministrazione pubblica che spesso la propaganda fascista ostentava come fedelissima del partito, in realtà non era assolutamente così fascista
- La maggior parte dei cechi e dei russi avevano disertato portando con sé armi e munizioni
- Per Andrea Caffi federalismo internazionale e infranazionale devono completarsi a vicenda
- Significativo che Silvia Rivera Cusicanqui abbia voluto tradurre il lavoro degli studi subalterni indiani in spagnolo
- In Valtellina alla vigilia del più grande rastrellamento nazifascista
- Freddi con discutibile lungimiranza preconizzava un’imminente morte del divismo americano
- Ci si propone di seguire il percorso dei soggetti legati all’Autonomia bolognese
- Si è verificato un mutamento di prospettiva circa il rapporto tra letteratura e Resistenza
- A partire da questi anni i nuovi bersagli oggetto di contestazione e battaglia della destra furono i luoghi di studio e di critica del pensiero
- A febbraio 1980 sul caso Caltagirone-Italcasse emerge una serie di aspri contrasti all’interno degli uffici giudiziari romani
 Frammenti di storia
Frammenti di storia- Il Comitato italiano dei Partigiani della pace tenne il suo primo Congresso generale nel 1954
- A metà settembre la 34a Divisione della Wehrmacht, che da un anno occupava la provincia di Savona, fu avviata al fronte delle Alpi Marittime
- Come in altri paesi abruzzesi il comando tedesco obbligò sotto minaccia alcuni cittadini ad un servizio di guardia
- Agli inizi degli anni ’70 la terra e la fabbrica, i due simboli che avevano tenuto insieme per decenni la società civile lombarda, andavano scomparendo
- La Resistenza francese espresse idee costituzionali molto diversificate tra loro
- Agli occhi di Washington, tuttavia, l’importanza dell’Italia nel secondo dopoguerra era ancora piuttosto marginale e periferica
- Il primo periodo buio dei GAP a Milano si apre agli inizi di febbraio 1944
- Il film si presenta come una vera e propria favola
- Una certa insoddisfazione dei dirigenti confindustriali in merito all’azione “accademica” dell’Interdoc
- Scassellati trasportò nel comando i metodi sanguinari usati nella controguerriglia in Dalmazia
 Vecchi e nuovi racconti
Vecchi e nuovi racconti- Genova (2)
- Un po' prima dei carri de "I Galli del Villaggio"
- Il macchinista francese venne espulso
- Marché aux fleurs
- Francesco Lanteri e Giobatta Lanza, di Triora, fucilati in una imprecisata rappresaglia nazifascista
- ... il Gruppo Sbarchi Vallecrosia
- Profumi
- Calvino non poteva non essere riconosciuto
- Genova (1)
- Camicie con la seta dei paracadute
-
Articoli recenti
- Lontanissimi dalle colline “materne” e consolatorie di Fenoglio, qui si trovano luoghi ostili, per niente rassicuranti
- La P2 si trasformò a partire dal 1977 in una sede di raccordo e di incontro delle strutture parallele, che gestivano il potere reale in Italia
- A partire dall’immediato dopoguerra il gruppo dirigente comunista organizzò in modo sempre più articolato la comunicazione politica e la propaganda ideologica
- Gli Stati Uniti attribuivano all’Italia esclusivamente un ruolo di sicurezza anti-sovietica
- La zona di Quiliano era nevralgica per i garibaldini
Archivi
Meta