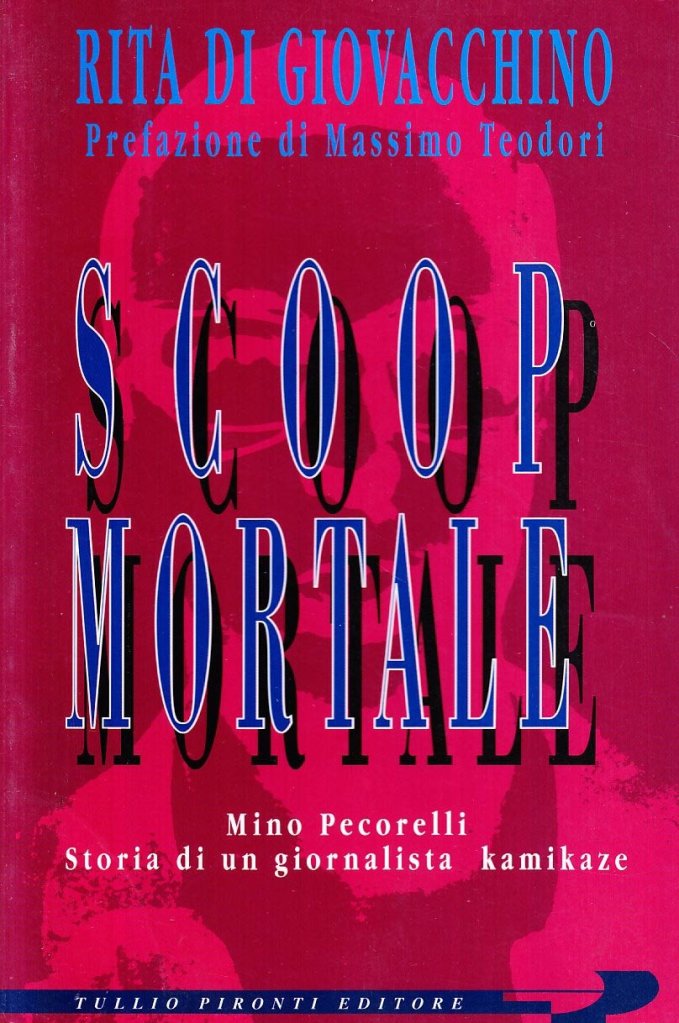Pecorelli non dava troppa enfasi agli assassinii e agli atti di terrorismo, il suo era uno sguardo diverso, penetrato negli androni dei Palazzi, tra le carte e i documenti, le missive e i dispacci segreti, le note interne e le frasi sussurrate. Gli anni più convulsi e tempestosi della recente storia italiana, gli anni della strategia della tensione e del terrore, che dalla strage di Piazza Fontana arrivarono fino alla strage di via Fani, culminando con il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro, non erano la sola opera della bande criminali disseminate sul territorio che, in genere, si dimostravano come affidabili esecutori materiali, ma di un potere violento e disposto a tutto, ben saldo e protetto nelle poltrone degli edifici settecenteschi, tra tele prestigiose e affreschi dall’inestimabile valore storico. Tra interdipendenze e relazioni cosi difficili da definire, vanno ricercati mandanti, collaboratori, mediatori e mani armate. Pecorelli ha finito per lasciarci la pelle, lui parlava troppo, lui sapeva troppo, era un moto perpetuo di informazioni velate che, una sera di marzo, si è interrotto, trivellato da quattro proiettili. Lo dimostrano le note al veleno che apparivano su OP-Osservatorio Politico Internazionale, indirizzate alle più eminenti personalità dell’Italia istituzionale, militare e finanziaria. Un uomo così ben inserito, che aveva accesso a documenti segreti e nascosti, non possiamo considerarlo estraneo alla scena nazionale fin qui brevemente esposta. Anche lui, come gli altri, faceva parte o ne era espressione, di quel sottobosco politico, di quei poteri occulti che rappresentano le cause dei mali italici.
Per questo l’elaborato non vuole elogiare o riabilitare Pecorelli, ma vuole delineare un quadro della sua vita e della sua attività all’interno degli anni più bui della recente storia tricolore. Partirò, per tessere i fili di questo ingarbugliato enigma, dalla figura stessa del Pecorelli, dalla sua vita di paesano alla sua esperienza professionale di giornalista, con uno sguardo tra le carte dei tribunali che avevano in carico l’inchiesta sul suo delitto. Conclusa questa parte, l’obbligo è quello di analizzare le righe dello scapestrato e impavido giornalista, il suo verbo allusivo e ammiccante, il suo prodotto denso di riferimenti ai “segreti e segretissimi” affari di stato, la sua rivista luccicante e patinata che, per la prima volta, compariva nelle edicole, pronta per entrare nelle case a rivelare le oscene trame del tricolore. Qui, c’è quindi tutto il Pecorelli, la vita e le opere. Ma la mia voglia è quella di saperne di più, di capire come questa vita si sia intrecciata con altre, sempre sullo sfondo dello stato (più che della società civile). Ecco allora tutti quei personaggi e quegli organismi che hanno fatto la recente storia d’Italia: Andreotti, Servizi Segreti, Rovelli, Gelli, Moro, Italcasse, Banda della Magliana, Dalla Chiesa, Mafia e così via. E, come disse Henry Kissinger, l’ex segretario di stato americano ai tempi della presidenza Nixon, “L’Italia è un Paese di molti misteri, ma di nessun segreto”. Noi gli crediamo.
[…] “Notizie, si sa, ad un certo livello non esistono. Esistono invece fughe di notizie. Cioè quelle soffiate, quelle indiscrezioni con cui ciascun centro di potere in questa Repubblica pluralistica cerca di condizionare, ammonire, minacciare altri centri di potere. In questo senso, parlare di “giornalisti spia” è parlare di acqua fresca. Il giornalista è insieme una spia e il suo contrario. Spia in quanto per accedere a certe informazioni deve stabilire dei contatti con determinati centri di potere, magari tappandosi il naso, ma senza timori virginali sul candore delle proprie mani. Antispia, perché offre subito al suo pubblico ogni indiscrezione della quale entra in possesso. Il giornalista, insomma, può correre il rischio di diventare uno strumento altrui, può non comprendere subito dove andranno a sfociare iniziative determinate alle sue spalle, ma certo mai e poi mai uno che ha il vizio della penna potrà prestarsi alle clandestine omertà del mondo spionistico”. È quanto scriveva, a proposito del proprio lavoro, Mino Pecorelli, in un inconsapevole epitaffio che precedeva di circa due anni la sua morte. Forse, con questa citazione, paiono risolte le domande iniziali. Lo stesso Pecorelli era consapevole del suo ruolo, di essere un personaggio di “rottura”, sospeso tra i “centri di potere” e il “suo pubblico”. Sosteneva di essere un “giornalista libero, conscio dei compromessi e dei rischi connessi alla sua missione”: quella, cioè, di raccontare i rapporti dei vertici dello Stato, di svelare i retroscena dei “palazzi”, di rendere pubblico ciò che doveva rimanere segreto e misterioso.
Massimo Teodori, nella sua prefazione al libro di Rita Di Giovacchino, “Scoop Mortale, Mino Pecorelli storia di un giornalista kamikaze”, scrive: “…che a tutti gli effetti possiamo inscrivere nella grande tradizione americana dei muckrakers…”, riferendosi al giornalismo pecorelliano.
Una mina vagante che non risulta “organica” a nessun establishment di potere, a nessun gruppo ufficiale, semiufficiale o occulto. Certo Pecorelli ha mantenuto costanti rapporti con molteplici gruppi di potere, li ha difesi in varie occasioni ma, sottolineando la sua natura, li ha anche attaccati, pure ferocemente. Questo, come vedremo nel proseguo dell’elaborato, ci spinge a dire (e ribadire) come Pecorelli non può essere inscritto a nessun “partito” della Prima Repubblica, anche se il suo nome compare in molti “sottoscala, retrobottega e saloni del vecchio regime”. Seguendo le riflessioni di Teodori, possiamo iniziare una disamina circa le “pecorelliane investigazioni”, facendo riferimento al nostrano “giornalismo investigativo”, più che alla tradizione d’oltreoceano.
Partiamo con una definizione: “…a differenza della semplice ricerca, ad esempio, l’investigazione è fortemente connessa con la dimensione del rischio e della ritorsione. Il giornalismo investigativo non va confuso con la cronaca giudiziaria o con la cronaca nera, con il giornalismo d’opposizione o di denuncia, con lo scoop o la punditry, con il chequebook journalism o con la controinformazione, e soprattutto con l’inclinazione amatoriale a spulciare una verità tenebrosa…Di norma il giornalismo investigativo è un lavoro di gruppo: richiede un team, un project editor e soprattutto una professionalità caratterizzata da conoscenze precise in vari campi…richiede una cultura dell’investigazione e della legalità, del dettaglio e del riscontro, dell’indizio e della prova…è un tipo di giornalismo che, sulla base della competenza e non del semplice fiuto, tenta di scoprire meccanismi casuali, protagonisti nascosti, sconosciute successioni temporali e motivazionali…Vuole scoprire e ricostruire i fatti, non si limita ad una narrazione…è scomodo e impegnativo: procura spesso nemici e avversità, perché quella verità investigata è tenuta accuratamente nascosta da qualcuno che, come minimo, è pronto ad adire le vie legali per evitare che le proprie attività siano rese note…”. Senza nulla togliere agli altri modelli e tipi di giornalismo (come la nera, ad esempio, che ha reso celebri personaggi del calibro di Gadda, Sciascia, Pasolini e Camilleri), il giornalismo investigativo assume un rilievo particolare per il semplice fatto che unisce (o perlomeno dovrebbe unire) esperienze precise in vari campi “…sotto il profilo metodologico, sociologico, giuridico, per quanto riguarda la teoria della conoscenza, la sociologia delle comunicazioni, il diritto penale dell’informazione…”.
Luca Signorini, L’Op e Mino Pecorelli: un giornalismo tra investigazione e mistero, Tesi di laurea, Università degli Studi di Firenze, Anno accademico 2008-2009
Il documento di Sica partiva dall’inchiesta sull’assassinio Pecorelli del marzo 1979 per rammentare che documenti relativi a Licio Gelli e alla P2 erano stati ritrovati fin da allora. Pecorelli aveva infatti un appunto da cui risultava che “Gelli era stato officiato per interferire nella nomina del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e che la massoneria voleva il processo a carico di Vito Miceli per consentirgli dì attaccare pubblicamente l’on. Giulio Andreotti”. <324
L’azione della Procura romana aveva portato ad un vigoroso attacco mediatico. Domenico Sica nel suo documento aveva omesso di spiegare perché tali documenti erano rimasti a riposare per anni saltando fuori solamente dopo che i giudici milanesi Giuliano Turone e Gherardo Colombo avevano sequestrato parte dell’archivio di Gelli <325. Franco Scottoni, su “Repubblica” commentava: “Gallucci ha ricordato soltanto che in caso di conflitti di competenza l’ultima decisione spetta alla suprema Corte di cassazione. Purtroppo l’esperienza fatta in passato, in particolare per alcune inchieste scottanti lascia presagire che quando vengono sollevati conflitti di competenza c’è qualcosa che cova sotto il fuoco. Il più delle volte i conflitti preannunciano affossamenti e depistaggi. Sarà così anche per la P2?” <326.
[…] Perché era vero che il capo della Loggia P2 conosceva il direttore della rivista “OP” Mino Pecorelli. Era una conoscenza nata dalla comune amicizia con il senatore Egidio Carenini, sottosegretario democristiano del ministero dell’Industria e del Commercio nel biennio 1974-1976, che lo stesso Gelli aveva ricordato nel 2006, quando ammise di vedere Pecorelli “tutte le settimane per una colazione: io, Mino e Carenini. Parlavamo di tutte le notizie che in quel momento potevano avere un particolare interesse. Pecorelli era una persona preziosa perché in caso di necessità avrebbe potuto aiutarci con la sua penna”. <437
Eppure Pecorelli, ucciso da mano ignota nel marzo del 1979, non aveva certo aiutato il capo della P2 “con la sua penna”. Basti pensare che dal gennaio 1979 “Osservatorio Politico” non aveva fatto altro che attaccare il Venerabile Maestro uscendo con articoli di inedita durezza. Era il caso del servizio su “Massoneria: finalmente la verità sul Venerabile della P2 – due volte partigiano”. All’interno Pecorelli raccontava in esclusiva le mille vite di Gelli collaboratore dei fascisti e dei nazisti prima, doppiogiochista poi, partigiano infine. Inoltre, nell’ultima uscita di “OP” il 20 marzo 1979, Pecorelli pubblicava un dossier, “La massoneria: è ancora una cosa seria quella italiana?”, in cui si denunciavano “attentati, stragi, tentativi di golpe, l’ombra della massoneria ha aleggiato dappertutto: da Piazza Fontana al delitto Occorsio, dal golpe Borghese alla fuga di Sindona”. <438
[…] Inoltre alcuni giorni prima dell’assassinio di Mino Pecorelli, chiacchierato direttore della rivista “Osservatore Politico”, il giornalista era andato a trovare a casa il generale Maletti e lo aveva informato che stava per uscire un servizio di “OP” che avrebbe infastidito molte persone: “Aggiunse che proprio per evitarne la pubblicazione, un certo politico aveva cercato di comprare l’uscita offrendogli una cifra che lui definì irrisoria. Io gli chiesi chi gli avesse offerto quel denaro; e lui rispose che era stato Gelli. Allora io gli chiesi: “per conto di chi lo ha fatto?”, “per conto di Andreotti.” E aggiunse: “Cosa vuole, che mi venda per così poco?”. […] Poco dopo mi strinse la mano e se ne andò. Uscendo da casa mia ricordo che ci salutò dicendo: “Arrivederci….forse”. Mi è rimasto impresso perché aveva gli occhi lucidi e, nell’accomiatarsi accennò quasi un abbraccio, verso me e mia moglie”. <484
[NOTE]
324 CP2, Documentazione raccolta dalla Commissione, Documenti citati nelle relazioni, 2-quarter/3, Tom. V, Vol. III, Documenti inerenti il conflitto di competenza tra la Procura della Repubblica di Roma e la Procura della Repubblica di Milano, in ordine al procedimento penale a carico di L. Gelli ed altri, pp. 309 e ss.
325 I giudici di Milano: No all’avocazione per la P2, «L’Unità», 24 giugno 1981.
326 F. Scottoni, «La Repubblica», 25 giugno 1981.
437 S. Neri, Parola di Venerabile, Aliberti, Reggio Emilia, 2006.
438 L’articolo si trova in CP2, Servizi segreti, eversione stragi, terrorismo, criminalità organizzata, traffico di droga, armi e petroli, Pecorelli e l’agenzia O.P., 2-quater/VII, tomo XVI, p. 387-389.
484 A. Sceresini – N. Palma – M. E. Scandaliato, Piazza Fontana, noi sapevamo: golpe e stragi di Stato. La verità del generale Maletti, Aliberti, Roma, 2010, p. 185 e ss.
Lorenzo Tombaresi, Una crepa nel muro. Storia politica della Commissione d’inchiesta P2 (1981-1984), Tesi di dottorato, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Anno Accademico 2014-2015